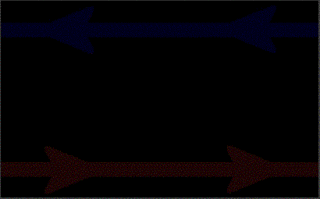![La macchia solare AR2529 fotografata il 13 aprile 2016, confrontata alle dimensioni della Terra. Crediti: Karzaman Ahmad, Langkawi National Observatory in Malaysia]()
La macchia solare AR2529 fotografata il 13 aprile 2016, confrontata alle dimensioni della Terra. Crediti: Karzaman Ahmad, Langkawi National Observatory in Malaysia
L’assenza totale di macchie solari che finora caratterizzava il periodo di minima attività magnetica solare nell’attuale ciclo undecennale è stato bruscamente interrotto qualche giorno fa, quando sulla superficie del Sole è comparsa una cosiddetta “regione attiva”, contraddistinta dalla sigla AR2529. Questa primizia solare, ritenuta una macchia poco attiva, presentava la caratteristica di ricordare una forma “a cuore”.
Gli scienziati si sono dovuti ricredere sull’apparente carattere tranquillo di questa macchia solare quando il satellite SDO della NASA, lo scorso 17 aprile, l’ha osservata produrre un brillamento (flare) di media entità (classe M 6.7).
I brillamenti solari sono potenti esplosioni di radiazioni. Si tratta di radiazioni potenzialmente nocive per gli esseri umani, che vengono fortunatamente schermate dall’atmosfera terrestre. Il pericolo maggiore è rappresentato dalle interferenze che i fenomeni più energetici di questo genere possono portare ai satelliti in orbita attorno alla Terra. Anche per questo motivo, i brillamenti sono di particolare interesse per gli scienziati.
![Il brillamento solare originato da AR2529 il 17 aprile 2016 ripreso dalla sonda NASA SDO]()
Video del brillamento solare originato da AR2529 il 17 aprile 2016 ripreso dalla sonda NASA Solar Dynamics Observatory. Si nota anche un anello di plasma scaturire sul lato destro. Crediti: NASA/SDO/Goddard
I flare vengono creati quando l’intreccio dei campi magnetici si riorganizza in maniera improvvisa ed esplosiva, convertendo energia magnetica in luce attraverso un processo chiamato riconnessione magnetica. Almeno questo dice la teoria, difficile da provare dal punto di vista sperimentale perché i segni distintivi di tale processo sono difficili da individuare.
Ora è stato pubblicato un nuovo studio a sostegno della correttezza di questa interpretazione dei brillamenti solari. Si tratta d’una ricerca basata sulle osservazioni che tre telescopi spaziali solari sono riusciti a realizzare durante un brillamento solare del dicembre 2013, ottenendo la visione più completa di un fenomeno elettromagnetico chiamato corrente diffusa (current sheet).
![Animazione del brillamento solare del 3 dicembre 2013 visto contemporaneamente dalle sonda americane SDO e STEREO e giapponese HINODE. La corrente diffusa è una struttura lunga e stretta, riconoscibile specialmente nelle viste di sinistra. Crediti: NASA/JAXA/SDO/STEREO/ Hinode (courtesy Zhu, et al.)]()
Animazione del brillamento solare del 3 dicembre 2013 visto contemporaneamente dalle sonda americane SDO e STEREO e giapponese HINODE. La corrente diffusa è una struttura lunga e stretta, riconoscibile specialmente nelle viste di sinistra. Crediti: NASA/JAXA/SDO/STEREO/ Hinode (courtesy Zhu, et al.)
A differenza di altri eventi “climatici” spaziali, come ad esempio le espulsioni di massa coronale, i brillamenti solari viaggiano alla velocità della luce. Ciò significa che non abbiamo alcun segnale anticipatore del loro arrivo. Sicché gli scienziati vogliono arrivare a definire i processi che portano alla creazione dei brillamenti solari: la speranza è quella di riuscire, prima o poi, a prevederli con qualche giorno di anticipo.
«L’esistenza di una corrente diffusa è cruciale in tutti i nostri modelli che predicono l’evoluzione dei brillamenti solari», dice James McAteer, astrofisico presso la New Mexico State University e tra gli autori del nuovo studio. «Così queste osservazioni ci rendono molto più sicuri e rilassati».
![Modello di “current sheet”. Crediti: ESA]()
Riconnessione magnetica. Crediti: ESA
Una corrente diffusa è un flusso molto veloce e molto piatto di materiale elettricamente carico, definito in parte dallo spessore estremamente ridotto rispetto alla estensione. Le correnti diffuse si formano quando due campi magnetici allineati in modo opposto entrano in stretto contatto, creando una pressione magnetica molto alta. La corrente elettrica che scorre attraverso questa zona ad alta pressione è fortemente compressa, come fosse “laminata”. Questa configurazione di campi magnetici è instabile, una condizione che può facilmente portare alla riconnessione magnetica.
« La riconnessione magnetica accade nell’interfaccia tra campi magnetici allineati in modo opposto», spiega Chunming Zhu, scienziato spaziale alla New Mexico State University e autore principale dello studio. «I campi magnetici si spezzano e si riconnettono, dando origine a un brillamento solare».
Non è naturalmente la prima volta gli scienziati osservano una corrente diffusa durante un brillamento solare, ma questo studio, secondo gli autori, è unico, in quanto diverse proprietà della corrente diffusa – quali velocità, temperatura, densità e dimensioni – sono state osservate contemporaneamente da più angoli di vista, oppure derivate da più di metodo di analisi.
Un altro studio appena pubblicato su Scientific Reports, una rivista scientifica affiliata a Nature, propone un ulteriore record nel campo dei brillamenti solari. Gli scienziati del New Jersey Institute of Technology (NJIT) hanno catturato al Big Bear Solar Observatory (BBSO) immagini senza precedenti di un brillamento solare, esploso il 22 giugno 2015. Secondo gli scienziati, si tratta delle immagini con maggiore risoluzione per questo genere di osservazioni.
![Ripresa del telescopio NST (a dx) confrontata con quella del satellite SDO (a sx). Crediti: NJTI]()
Ripresa del telescopio NST (a dx) confrontata con quella del satellite SDO (a sx). Crediti: NJTI
Nella straordinaria galleria ottenuta dal telescopio New Solar Telescope (NST) di 1.6 metri vi sono cose che noi umani non possiamo neanche immaginare: nastri di bagliori luminosi che attraversano una macchia solare, seguiti da una pioggia di plasma coronale che si condensa nella fase di raffreddamento poco dopo il brillamento, “annaffiando” la superficie visibile del Sole di esplosive gocce luminose.
Le nuove immagini permettono di comprendere meglio uno degli enigmi centrali della fisica solare, ovvero come l’energia venga trasferito da una regione del Sole all’altra durante e dopo un brillamento solare. «Possiamo ora osservare in dettaglio molto fine come l’energia sia trasportata nei brillamenti solari», commenta Ju Jing, professoressa al dipartimento di fisica del NJIT e autrice principale dello studio. «In questo caso dalla corona, dove è stato conservato, alla bassa cromosfera, decine di migliaia di miglia più in basso, dove la maggior parte dell’energia è stata infine convertita in calore e irradiata via».
![Ju Jing. Crediti: NJTI]()
Ju Jing. Crediti: NJTI
Ju sottolinea che, mentre i fasci di elettroni sono tradizionalmente visti come l’agente principale per il trasporto di energia nei brillamenti, le recenti osservazioni forniscono nuove informazioni sulla scala spaziale a cui avviene il trasporto di energia.
Anche in questo caso, i ricercatori sperano che i loro risultati possano portare a una migliore comprensione dell’impatto che brillamenti possono avere sulle attività Terrestri.
«Le nostre misure colmano il divario tra modelli e osservazioni, aprendo anche interessanti quesiti per ricerche future», commenta in conclusione Ju. «Saremo in grado di misurare, ad esempio, con i telescopi terrestri di grandi dimensioni queste caratteristiche sulla superficie del Sole fino alla loro scala spaziale fondamentale?».
Per saperne di più:
Fonte: Media INAF | Scritto da Stefano Parisini